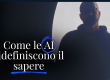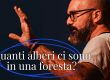In questi giorni sono alle prese con le anteprime di HI!, il mio primo film in uscita su Amazon Prime Video, e l’altra sera rivedendo il film a un certo punto mi sono domandato se posso dire di “essere” un regista, oppure semplicemente “ho fatto” il regista?
C’è differenza tra ciò che “facciamo” e ciò che “siamo”? Perché mai una medesima attività, svolta con le stesse competenze e la stessa passione, potrebbe farci sentire “qualcosa” o solo “qualcuno che fa qualcosa”?
In tanti ambiti, la distinzione tra “fare” ed “essere” si rivela cruciale. Storicamente, la società umana ha spesso creato ruoli che corrispondono a un’identità: sacerdoti, guerrieri, contadini, artigiani… Essere un soldato, ad esempio, implicava un senso di appartenenza a un gruppo definito e, in alcuni casi, persino a una casta. Non si trattava soltanto di “combattere” – un’azione – ma di incarnare un ruolo esistenziale, con i suoi codici e la sua morale.
Oggi, la percezione della nostra identità professionale è più flessibile. Possiamo “fare” più mestieri diversi nell’arco di una vita e reinventarci rapidamente se cambiamo paese o settore. Eppure, proprio questa duttilità ha prodotto una sfumatura emotiva curiosa: proviamo un senso di appartenenza profonda (essere), oppure sentiamo di “interpretare” un ruolo che non ci appartiene del tutto (fare)?
Per mesi, in realtà per più di un anno, sono stato immerso nelle ricerche, nelle riprese e nel montaggio. Insieme alla crew ho curato ogni dettaglio, ho immaginato scenari, ho preso decisioni creative ogni giorno. Eppure, terminata quest’avventura, sono qui a chiedermi se questo mi rende “un regista” o se è stato solo uno sforzo necessario per “fare il regista”.
C’è una dimensione, forse, legata alla fatica emotiva. Alcuni ruoli, per quanto possiamo svolgerli anche bene, ci consumano energie psicologiche preziose. È come se, ogni volta, dovessimo sforzarci di entrare in una parte che può essere anche ammaliante, ma che ci provoca disagio.
Una delle cose che faccio spesso ad esempio è lo speaker negli eventi, dove sono chiamato a salire su un palco per parlare al pubblico. Anche se lo faccio da vent’anni, ogni singola volta sento un certo disagio che mi porta a dire che posso “fare” lo speaker, ma non per questo sento di “essere” uno speaker.
Al contrario, quando ci dedichiamo a qualcosa che per quanto impegnativo ci fa sentire pienamente allineati con noi stessi, il senso di fatica può emergere sul piano fisico, ma non ci svuota sul piano emotivo. Invece di fare resistenza, sentiamo che ogni passo ci avvicina a un’espressione più profonda di ciò che siamo. È forse qui che scatta la percezione di “essere” e non più di “fare”.
Tornando allora alla domanda iniziale, la risposta potrebbe risiedere non tanto nel numero di film girati, né nel riconoscimento esterno, ma nel grado di serenità interiore che accompagna il processo creativo.
Ripensandoci, l’atto di dirigere un docufilm – per quanto complesso e stancante – non mi ha mai stressato, anzi spesso mi ha dato energie che non credevo di avere.
In altre parole, la differenza tra “fare” ed “essere” affonda le radici nel rapporto tra l’attività e la nostra identità più profonda. Se ci sentiamo compressi in un ruolo, quasi costretti, allora stiamo “facendo”. Se invece lo abitiamo con agio e pienezza, se è un’estensione naturale di noi stessi, allora stiamo “essendo”.
Questa distinzione, in fin dei conti, è una delle grandi sfide dell’uomo contemporaneo: trovare un equilibrio tra flessibilità e autenticità. Nell’era della specializzazione esasperata e della competizione globale, in una società che ci vuole sempre più produttivi e performanti, vale la pena domandarsi: sono ciò che faccio, o mi sto solo prestando a un sistema che esige risultati?
Ognuno di noi ormai impara a fare mille mestieri, a indossare tanti cappelli. Ma è quando uno di quei cappelli – magari il più difficile da gestire – ci regala uno spazio di crescita e benessere anziché di oppressione, che possiamo affermare di “essere” davvero.
🌎 Cerco di capire come un mondo complesso sta cambiando le nostre vite.🌎 Cerco di capire come un mondo complesso sta cambiando le nostre vite.
🌎 Cerco di capire come un mondo complesso sta cambiando le nostre vite.
Linkedin page opens in new window Instagram page opens in new window YouTube page opens in new window TikTok page opens in new window
Newsletter